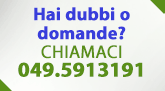Il digiuno per tutti
Basta un giorno alla settimana per un corpo sano e una mente lucida
Momentaneamente
non disponibile
- 14,16 € invece di € 14,90 Sconto del 5%
- FORMATO: Libro cartaceo - 224 pag
- AUTORE: Stefano Erzegovesi
- EDITORE: Vallardi Editore
- ANNO STAMPA: Febbraio 2019
- EAN: 9788869878558
-
FAI LOGIN E VOTA IL PRODOTTO:
-
 Aggiungi ai preferiti -
Scrivi Recensione -
Invia ad amici
Aggiungi ai preferiti -
Scrivi Recensione -
Invia ad amici -
- CATEGORIE DI APPARTENENZA
- Digiuno - Libri
- APPROFONDIMENTI
- Descrizione - Indice del libro - Il Gusto alla Mente. Chi sono, da dove vengo, dove vado -
MINIMO IMPEGNO, MASSIMA RESA
Un metodo accessibile a tutti per ritrovare la salute del corpo e della mente
BASTA UN GIORNO A SETTIMANA
Tanti libri si limitano a dire che il digiuno fa bene, questo libro ci insegna come farlo davvero.
Lo psichiatra e nutrizionista Stefano Erzegovesi ha messo a punto il sistema definitivo, semplice ed efficace per spegnere la fame e accendere la mente.
Non si tratta di una dieta ma di un vero e proprio metodo, basato su un giorno di digiuno, o meglio di magro, alla settimana.
Il digiuno è la pratica più all'avanguardia nel campo dell’alimentazione e della salute: i suoi benefici per il corpo e per la mente sono stati ampiamente riconosciuti e comprovati dai maggiori studi scientifici. Tuttavia, l'idea di saltare uno o più pasti spaventa molte persone.
Oggi, uno dei massimi esperti italiani di nutrizione ci spiega un metodo alla portata di tutti, in grado di garantire un benessere che va ben oltre il «peso ideale», per farci non solo stare, ma anche sentire meglio.
Il professor Erzegovesi ci aiuta a riacquistare la capacità di riconoscere sensazioni ed emozioni, come fame e sazietà, a differenza delle classiche diete rigide che ci fanno disperdere energie su pensieri astratti (come la conta delle calorie) o su traguardi di peso irraggiungibili.

Momentaneamente
non disponibile
Il digiuno per tutti
Basta un giorno alla settimana per un corpo sano e una mente lucida
Il gusto alla mente
SOMMARIO
Chi sono, da dove vengo, dove vado
PRIMA PARTE - Il Digiuno degli Altri
1 - Ho fame con tutte le diete del mondo
La storia di Laura
2 - Devastato dalla ciccia e dalle diete
La storia di Artemio
3 - Un amico di vecchia data
Il digiuno nella storia e nelle religioni
4 - Un motore super-speciale
Fisiologia della fame e della sazietà
5 - La forza guaritrice della Natura
Corpo e mente durante il digiuno
6 - Digiuno, guerra, miglioramento di se stessi
L'esperimento di Ancel Keys
7 - Luna di miele da digiuno
La storia di Francesca
8 - La voglia, la pazzia
L'esperimento di Roy Lee Walford
9 - «Oggi non ho intenzione di morire» (Thor)
Gli effetti del digiuno secondo le linee di ricerca più recenti
10 - Il digiuno: un'occasione per conoscersi
Cibo e consapevolezza di sé
11 - Otto + 1 ricette per non mangiare
I principali schemi di digiuno intermittente e il nostro Giorno di magro
SECONDA PARTE - Il Nostro Digiuno
12 - «Che dottore palloso!»
Raccomandazioni e istruzioni prima di partire
13 - Il Giorno di magro: come organizzarlo
Aspetti molto pratici
14 - Tu chiamale, se vuoi, sensazioni
Sintomi fisici e mentali, belli e meno belli, dopo il Giorno di magro
15 - «E gli altri sei giorni cosa faccio?»
Linee-guida fondamentali per una sana alimentazione
Epilogo
«Che la pace sia con voi» ovvero: il tramonto del milanese incazzoso nel traffico
APPENDICI
I - Cortesie per gli ospiti
Digiuno, alimenti e flora intestinale
II - Il piacere di comunicare, per saperne di più
Riferimenti bibliografici
RICAPITOLANDO
Il digiuno per tutti: come si fa

Momentaneamente
non disponibile
Il digiuno per tutti
Basta un giorno alla settimana per un corpo sano e una mente lucida
Confesso che le prefazioni non mi sono mai piaciute. Mi verrebbe da chiedere: «Ma come, mi raccontate un libro che non ho ancora letto?»
Adesso tocca a me scrivere una prefazione, e non racconterò il libro, ma come ci sono arrivato.
Il mio prof di Filosofia del liceo citava una frase di Seneca che mi lasciava sempre con un brivido di paura: «Volentem fata ducunt, nolentem trahunt», cioè «Il destino accompagna e conduce colui che vuole farsi guidare, e trascina colui che non vuole». Trascina, addirittura! Nella mia vita di medico, psichiatra, nutrizionista e quasi-cuoco il destino, più che un trascinatore, è stato un sottile filo conduttore: per nulla invadente, delicato ma sempre visibile: come le briciole di Pollicino.
Ripensandoci, il destino non mi ha riservato una partenza proprio felice: ultimo di quattro fratelli, i primi tre decisamente brillanti, interessati a tutto, impegnati in mille attività e bravissimi a scuola; capite che è stato un attimo sentirmi «lo scemo di famiglia». Fortuna che a casa non ci si annoiava mai: come in uno strano gioco di inversione delle parti, la mamma napoletana, ben lungi dall'essere tutta belcanto, pizza e mandolino, ci stimolava ogni giorno ad andare nel profondo delle cose e a non accontentarsi mai. Il papà milanese, ben lungi dall'essere tutto polenta, lavorare e fatturare, era rigorosissimo sul lavoro ma ci intratteneva con musica, poesia (le sue rime improvvisate, spesso in occasione di feste e ricorrenze in famiglia, hanno ispirato i Motti di Fine Capitolo che troverete in questo libro) e un approccio alla vita guidato dall'emozione. Certo due caratteri così diversi litigavano spesso ma, come diceva papà Angelo (impersonato dall'attore Andrea Tidona) in quella meraviglia di film che è La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, «litigare fa bene, tiene in allenamento».
Io, nel mio piccolo, facevo quello che dovevo fare, con molto senso del dovere ma senza particolare entusiasmo. Anche la musica che, nelle tradizioni di casa non solo paterne, si amava ascoltare e suonare, era per me un prolungamento della scuola: Italiano, Matematica, Scienze a scuola; Chitarra classica, Teoria e Solfeggio, Storia della Musica al Conservatorio. Quindi scolaro discreto e studioso, musicista sufficiente e con poco talento.
Dicevamo di un destino non proprio facile all'inizio. Quando avevo sedici anni, Elisa, la sorella che mi era più vicina per età – aveva due anni più di me – è mancata per una leucemia acuta. Ricordo il dolore negli occhi dei miei genitori, un dolore difficile da spiegare per quanto era cupo e profondo, molto più cupo di quello di Elisa che, trascinata dalla vitalità dei suoi 18 anni, riusciva a vivere la malattia quasi con leggerezza. Ancora oggi, gli occhi dolenti dei miei genitori mi ricordano quanto sia importante accogliere e alleviare la sofferenza del paziente, ma anche quella delle persone che gli stanno accanto.
La situazione in casa era quella di una famiglia che cercava di sopravvivere con tutte le sue forze, e i miei ultimi due anni di liceo furono davvero terribili: non studiavo niente, quando tornavo da scuola restavo a casa a mangiare latte e biscotti e a guardare la televisione. Nell'anno della Maturità, alla fine del primo quadrimestre avevo 4 e 5 in tutte le materie. Però una sera, alla zia Lea, che era venuta a trovarci poco dopo che Elisa ci aveva lasciato e che mi aveva chiesto cosa volessi fare dopo il liceo, ho risposto che avrei voluto studiare Medicina. Non «forse farò Medicina», ma proprio, detto a me stesso molto più che alla zia: «Ma certo, farò il medico!»
Comprensibilmente, la reazione dei miei genitori fu un «no». Andavo male a scuola, era una facoltà dura, un corso di studi lungo... In realtà volevano solo proteggermi, perché in fondo sono certo che fossero contenti.
Intanto, trovai un alleato fuori dalla famiglia. Con la morte di Elisa, mia madre si era avvicinata alle «medicine alternative», e per aiutarmi in quel difficile periodo mi aveva mandato da Attilio Speciani, un medico specializzato in quel tipo di discipline. Fu lui a dirmi, nell'estate dell'esame di Maturità: «Tutti ti diranno che non devi fare Medicina, ma se tu senti che questa cosa è la tua cosa, falla». E aggiunse una frase che mi colpì: «E se cercano di convincerti del contrario, vengo io a difenderti con la lancia». Non fu necessario, perché da subito i miei genitori capirono che quello che stavo facendo era una cosa giusta per me. E non se la presero più di tanto quando annunciai loro che avrei interrotto gli studi al Conservatorio.
Durante il triennio clinico ebbi la conferma di essere sulla strada giusta: il contatto, finalmente diretto, con i pazienti mi trasmetteva un'energia incredibile, anche se nell'approccio alle patologie, a volte troppo meccanicistico, mi sembrava che mancasse qualcosa. Quando fu il momento di scegliere la specialità, pensai a Psichiatria, perché cercavo una specialità che sembrasse un po' più aperta, meno «protocollare».
La materia mi piaceva sempre di più e, forse, stavo uscendo dal bozzolo dello «scemo di famiglia»: da quando frequentavo l'ospedale avevo la metà del tempo per studiare eppure, come per miracolo, i voti agli esami erano tutti bellissimi. Mi viene in mente quello che ci raccontava don Pietro, il nostro prof di Religione al liceo: «Il fine dell'uomo è seguire il miracolo dell'amore!
Pensate ai soldi che avete in tasca, o alla merenda che avete sotto il banco: se li dividete con qualcuno, ce ne sarà di meno per voi. L'amore invece no: voi donate il vostro amore, le vostre energie a qualcuno, questo qualcuno si arricchisce ma vi arricchite anche voi, in barba a tutte le leggi del mercato!» Per me, il miracolo è stato studiare con molto meno tempo a disposizione, ma con più energia e amore per quello che stavo facendo.
Dopo la laurea iniziai la scuola di specialità di Psichiatria, lavorando in ospedale, al San Raffaele, come medico interno. Ebbi la fortuna di incontrare il professor Smeraldi, direttore del Dipartimento di Psichiatria dell'ospedale. Puntualissimo nel ricevermi, non accennò neanche lontanamente a cose del tipo «Tu chi sei? Chi ti manda? Sei parente o amico di qualcuno?» Mi chiese solo: «Dopo la laurea vuoi fare lo psichiatra?» Io risposi di sì e lui concluse: «Mi basta», dopodiché mi portò a fare un giro per il reparto, presentandomi personalmente tutti i suoi collaboratori.
Il mondo della psichiatria era (ed è ancora) molto fumoso: sulla conoscenza del cervello si stanno facendo passi da gigante ma, a oggi, le cose che non sappiamo del cervello sono molte più di quelle che sappiamo. Smeraldi ci diceva che prima di tutto dovevamo avere presenti due cose: quello che il paziente si aspettava da noi, e quello che noi ci aspettavamo da lui, o meglio cosa ci attendevamo dalla cura che gli avremmo prescritto: un modello che, oltre a funzionare, dava al paziente la sensazione che le cose non gli venissero «calate dall'alto».
Per tutto quel periodo, oltre all'università, frequentavo corsi nell'ambito delle medicine alternative, come fitoterapia, omeopatia e quella che si chiamava «alimentazione funzionale».
Nel corso degli anni, con l'esperienza clinica, ho ridimensionato moltissimo l'efficacia delle medicine alternative, ma allora mi piacevano perché avevano una visione globale della persona, non solo del «pezzo» da curare, e mi sembrava che arricchissero la relazione con il paziente. Sentivo che, anche nell'ambito clinico, dovevo fare qualcosa sul piano della comunicazione con i pazienti: la relazione non poteva essere un «calare dall'alto», ma neppure una relazione paritetica tra amici o conoscenti.
Anche qui, in maniera apparentemente casuale, il filo del destino mi ha condotto, mentre cercavo con fatica il giusto equilibrio nelle relazioni con i pazienti, al teatro. Per dieci anni ho frequentato un laboratorio teatrale e, anche se mi era piuttosto chiaro che non possedevo un granché di talento come attore, l'esperienza del «cosa succede davanti a una persona» si è rivelata importantissima nel mio lavoro di medico e psichiatra, importantissima perché «esserci» per il paziente non vuol dire soltanto dirgli le cose tecnicamente giuste, ma anche «stare accanto» a lui, in maniera presente e non giudicante. Più di due terzi dei pazienti si lamentano dei medici non sul piano strettamente professionale, ma su quello della comunicazione – «non mi ha mai guardato in faccia, non si è neanche presentato con il suo nome, ha passato il tempo a scrivere al computer...» Il teatro invece è proprio questo: tu sei lì, e, semplicemente «stando lì» nella maniera più vera possibile, devi arrivare al pubblico che sta dall'altra parte. Chiunque vi dica «sei un grande attore» intendendo che siete dei bugiardi, non ha capito nulla: un attore in teatro, per essere vicino a voi che lo ascoltate, deve essere «più vero del vero».
Conseguita la specializzazione in Psichiatria, al San Raffaele ho iniziato a occuparmi di disturbi d'ansia e disturbi ossessivi. Oltre a fare lo psichiatra esercitavo l'attività libero-professionale in «medicine complementari» come l'omeopatia e la fitoterapia.
Ed ecco un altro cambio di direzione sul filo del mio destino: un giorno del 2001, il primario mi chiese di seguire Francesca, una paziente anoressica che aveva già subito molti ricoveri e avuto altrettante recidive. Francesca stava letteralmente morendo di fame, ma mi disse: «Mi raccomando, se vado in rianimazione ditegli la dieta che faccio, non voglio che mi diano neanche una caloria in più. E comunque voglio decidere io».
La follia e, contemporaneamente, la grande lucidità di questa ragazza mi colpirono e illuminarono allo stesso tempo: alla fine, la sua ossessione per la magrezza e le calorie, che la divorava dal di dentro senza fermarsi mai, senza mai trovare un limite, non era tanto diversa dalle cellule maligne che avevano consumato mia sorella Elisa in così poco tempo. Iniziai quindi a occuparmi di anoressia, e dopo sei mesi venni nominato Responsabile dell'Unità Disturbi Alimentari del mio ospedale.
In ambito medico e universitario non si parlava di alimentazione come siamo abituati a parlarne oggi: si diceva «assumi tante proteine perché sennò non cresci, per l'energia ci sono i carboidrati» e così via.
Affrontare i disturbi alimentari richiedeva per forza un approccio diverso, anche perché di calorie, proteine e zuccheri le ragazze anoressiche ne sanno spesso molto più dei medici. Bisognava intervenire sul rapporto che intercorre, nei pazienti, tra quello che mangiano (o non mangiano) e ciò che accade nel loro cervello, e su come a sua volta ciò che accade nel loro cervello influenzi quello che mangiano. Discutevo con i dietisti e i nutrizionisti e loro mi parlavano, giustamente, di fabbisogni di proteine, carboidrati e grassi, ma nessuno mi spiegava perché le persone che curavamo cambiavano il modo di pensare a seconda di cosa mangiavano. Le ragazze anoressiche si trovavano di fronte a un nutrizionista, che prescriveva loro cosa mangiare, e a uno psichiatra, che le invitava a «comprendere i pensieri» e «ascoltare le emozioni». Ma perché nessuno chiedeva il legame che c'era tra pensieri, emozioni e cibo? Mi sembravano due linguaggi e due mondi separati. Ho pensato che avrei dovuto collegare questi due mondi, e così ho deciso di specializzarmi anche in Scienza dell'alimentazione, percorso che ho concluso nel 2013.
In quel periodo ho fatto due incontri fondamentali.
Il primo: per caso, nella sala d'attesa del mio dentista di allora, ho visto un video di Franco Berrino, grande medico, ricercatore ed epidemiologo che si occupa di alimentazione come strategia preventiva dei tumori e, più in generale, di alimentazione in un'ottica di miglioramento personale. Sosteneva che ciò che mangiamo influenza quello che pensiamo, e viceversa: riconobbi ciò che vedevo nei miei pazienti.
Il secondo incontro (durante un diluvio terribile, da arrivare in moto inzuppato da capo a piedi) fu a un seminario organizzato dalla Scuola di specialità in Scienza dell'alimentazione. Tra gli altri relatori venne invitato lo chef Pietro Leemann del ristorante di alta cucina vegetariana «Joia» di Milano. La cosa che mi colpì di più fu l'insistenza di Pietro sulla dimensione emotiva e spirituale del cibo: le scelte che compiamo mangiando ci possono cambiare anche spiritualmente.
Nel frattempo avevo iniziato a tenere dei laboratori di cucina con i pazienti, in ospedale, dove preparavamo cose molto semplici in un cucinino di 3 metri per 3. Contattai Leemann e gli chiesi se poteva aiutarmi nei laboratori di cucina con i pazienti. Lui, come tutte le persone geniali, rivoluzionò e capovolse i termini del discorso: non «Leemann nella cucina dell'ospedale di Erzegovesi» ma «Erzegovesi nella cucina di Leemann». A quel punto, allievo-cuoco novello della sua scuola professionalizzante di cucina vegetariana della «Joia Academy», ho scoperto cosa volesse dire vivere, dal di dentro, un'esperienza di scuola di cucina.
Per tutto quello che ho imparato, e non sto parlando solo di cucina, ma anche di intensità dell'esperienza e dei contenuti, quella scuola per me è stata ben più di un master universitario. Mi ha cambiato la vita in un senso molto pratico e quotidiano, ha migliorato il mio modo di mangiare, la mia salute e il mio modo di sentirmi vicino alla sofferenza dei pazienti.
Nel 2017, quando l'associazione «La Grande Via» di Franco Berrino e la «Joia Academy» di Pietro Leemann hanno organizzato insieme un corso di cucina Macro-mediterranea®, il cerchio si è chiuso. Frequentando il corso ho finalmente conosciuto di persona Franco Berrino, ho arricchito molto le mie conoscenze tecniche (i cibi fermentati in cucina, ad esempio, hanno cambiato il mio modo di pensare agli ingredienti e alla salute del nostro intestino; le tecniche per estrarre grandi sapori da un semplice brodo vegetale hanno trasformato il mio modo di pensare, da «il brodo è un ingrediente banale, alla fine è un po' di acquetta insaporita» a «il brodo è un vero piatto») e, soprattutto, si è ulteriormente rafforzata in me l'idea fondamentale del legame che unisce cibo, uomo e ambiente. Con buona pace dei razzisti, più un ambiente è biodiverso e multiculturale, meglio è per l'ambiente, che diventa più forte e più resistente alle perturbazioni esterne; allo stesso modo una verdura fermentata, più è ricca di microbi attivi e biodiversi, meglio sarà per la nostra pancia e per la nostra salute.
Visto che il filo del destino aveva iniziato ad andare verso la cucina, luogo di conoscenza, di fatica da condividere, di relazione e di apprendimento dei propri limiti, sempre nel 2017 arriva un regalo inatteso: il papà di una mia paziente dona al San Raffaele una somma da destinare alla costruzione di una cucina didattica, da dedicare interamente alla cura dei pazienti. Sono davvero grato a questo papà, che vorrei ringraziare pubblicamente con nome e cognome se non fosse per la privacy della piccola. Adesso, grazie alla proprietà del San Raffaele, che ha creduto in questo progetto con passione e determinazione (un pensiero di gratitudine particolare va alla dottoressa Gilda Gastaldi), abbiamo uno spazio perfettamente attrezzato e davvero bello e accogliente, in cui posso lavorare fianco a fianco con i pazienti e condividere con loro tutto quello che ho imparato e sperimentato.
E la condivisione continua fuori dall'ospedale, grazie alle opportunità di comunicare che mi sono state offerte da Progetto Itaca, Fondazione Veronesi, Corriere della Sera e Radio24, come spiego nelle pagine finali di questo libro.
Ma il digiuno, in tutto questo percorso, cosa c'entra?
C'entra il digiuno delle ragazze anoressiche: terribile, senza tregua, e che ci deve fare tenere alta la consapevolezza sui possibili gravi rischi di un digiuno prolungato e senza controllo medico.
Ma soprattutto, viste le sue incredibili potenzialità nella prevenzione e nella cura, il digiuno c'entra con i miei pazienti obesi resistenti, ovvero quei pazienti sfiniti dall'aver tentato decine di diete senza successo e che combattono ogni giorno contro la fame e il senso di fallimento. Con il digiuno possiamo aiutare loro e tutti i pazienti a dieta a essere più consapevoli della «fame vera» e, soprattutto, ad accettare la sensazione di «pancia vuota» come qualcosa di gestibile, non così insopportabile come temono.
«Pancia vuota», ma non troppo: dai miei studi di Scienza dell'alimentazione e dall'osservazione quotidiana delle ragazze sofferenti di anoressia sapevo che il digiuno prolungato poteva essere molto pericoloso e che astenersi totalmente dal cibo poteva anche aumentare il rischio di successive abbuffate.
Un digiuno simile a un tradizionale «Giorno di magro» – come lo chiamavano i nostri nonni – poteva scongiurare quei pericoli. Ho iniziato a studiare la letteratura scientifica sull'argomento e testi che se ne occupavano anche da un punto di vista divulgativo e molto pratico, avvicinandomi così all'idea del digiuno di due grandi ricercatori italiani, Valter Longo e Luigi Fontana, e di un brillante medico e divulgatore scientifico inglese, Michael Mosley: digiuno intermittente e a base di cibo vegetale.
Le piccole e grandi variazioni, che hanno portato al metodo che troverete in questo libro, sono arrivate dal contatto quotidiano con i pazienti: chi mi diceva che non ce la faceva a non mangiare nulla la mattina, o aveva la pancia che borbottava, o si sentiva stanchissimo, o aveva bisogno – bisogno! – di buoni sapori.
Siamo quindi arrivati alla mia idea di digiuno e di Giorno di magro: se iniziamo a prendere gusto a quello che mangiamo nel giorno di digiuno (quindi soprattutto le verdure), prenderemo gusto alle stesse cose tutti gli altri giorni, perché sono buone (non buone «così così», proprio buone da essere felici di finire il piatto!) e ci fanno stare bene. E il giorno dopo non sentiremo il bisogno di mangiare di più. Nella giornata di digiuno la nostra capacità di percepire la «fame vera» sarà più netta, la potremo riconoscere, impareremo a distinguere cosa è vera fame e cosa è noia o rabbia, quindi anche tutti gli altri giorni sapremo capire che possiamo anche ASPETTARE, prima di mangiare.
Saper distinguere la fame «vera» e le sue sfumature dai morsi della fame emotiva, che ti fanno mangiare qualsiasi cosa, significa avere un'arma in più: non siamo in balia di qualcosa che non possiamo controllare. Se abbiamo consapevolezza che ciò di cui abbiamo bisogno è davvero cibo, e non altro, sappiamo che «possiamo farlo»: possiamo SCEGLIERE di mangiare perché ne abbiamo davvero bisogno.
Quindi?
Quindi vale sempre la saggezza dei miei pazienti che spesso, durante gli incontri di gruppo, si dicono l'un l'altro «se ci sono riuscito io, ci puoi riuscire anche tu».
È l'augurio che mi sento di fare a voi che state per leggermi: che abbiate una patologia cronica o che abbiate bisogno di perdere peso oppure di guadagnare in salute e lucidità mentale, se ci sono riusciti loro, ci potete riuscire anche voi.
Usate allora questo libro come un manuale del piccolo esploratore nella giungla delle diete per il benessere.
Buona lettura!

Momentaneamente
non disponibile
Il digiuno per tutti
Basta un giorno alla settimana per un corpo sano e una mente lucida
Scritto da Isabella il 07/04/2022
I clienti che hanno scelto questo prodotto hanno acquistato anche...
 Catalogo generale
Catalogo generale